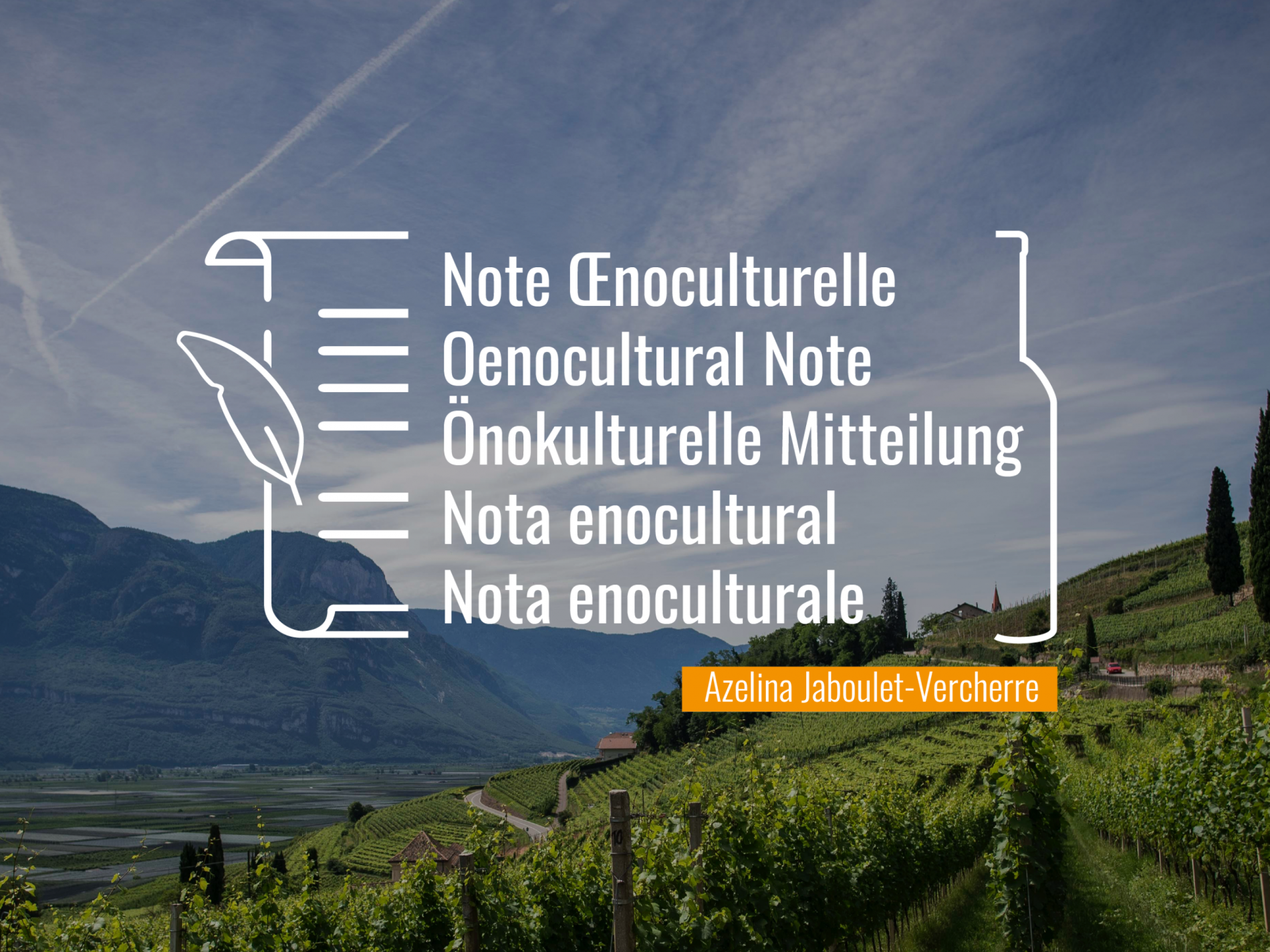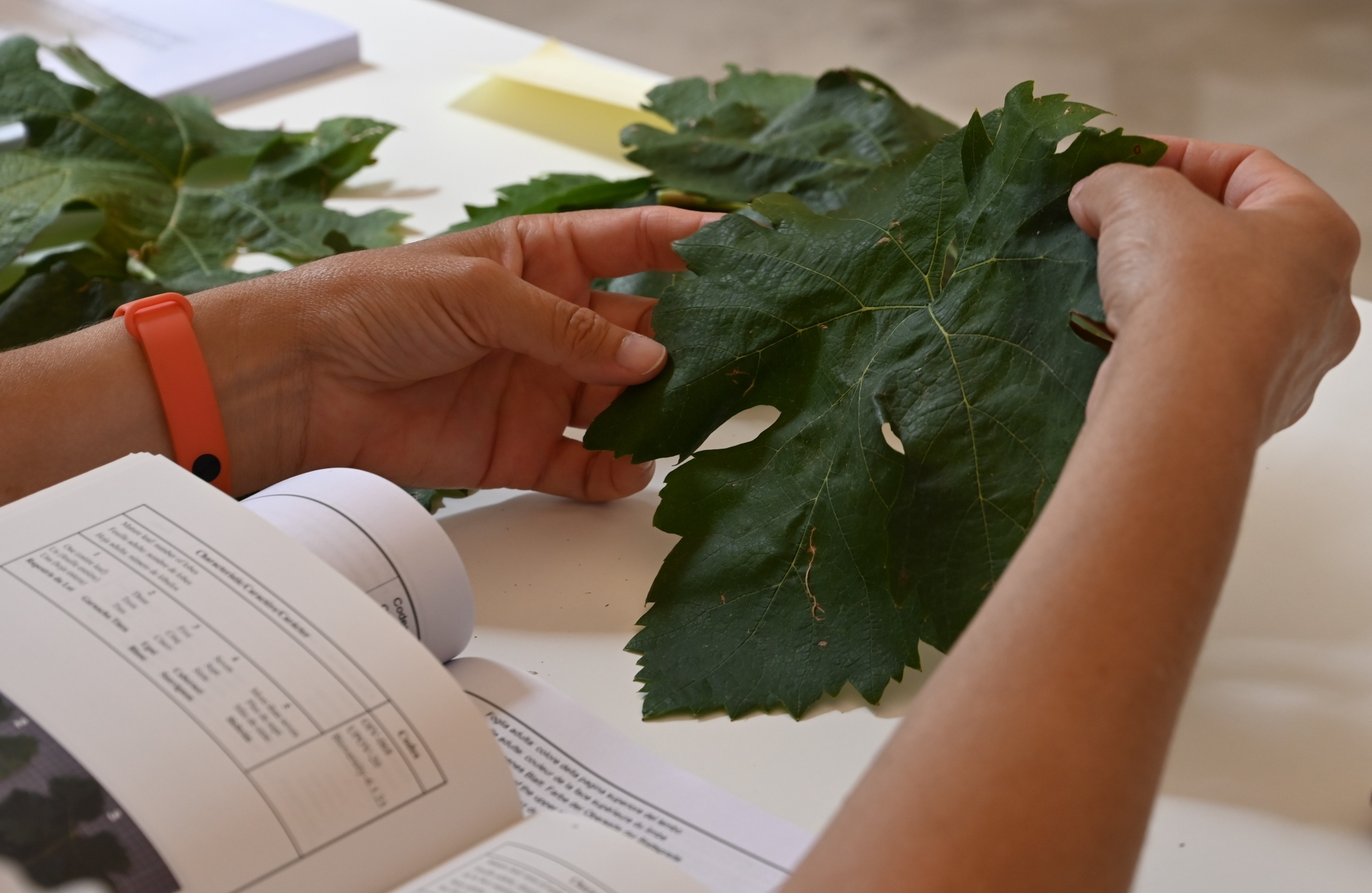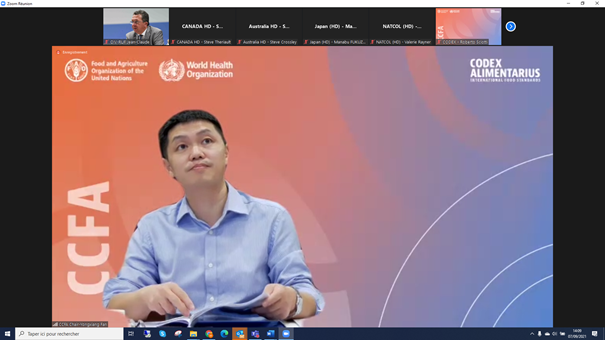28 Ott 2021
Parlando in una conferenza stampa telematica dalla sede parigina dell’OIV, il 27 ottobre il direttore generale Pau Roca ha presentato le prime stime sulla produzione vinicola mondiale del 2021.• Il volume di produzione atteso nell’UE è scarso, in particolare in Italia, Spagna e Francia, che registrano una riduzione complessiva di circa 22 Mio hl rispetto al 2020 a causa delle gelate primaverili tardive e delle condizioni meteo complessivamente sfavorevoli.• I soli grandi produttori di vino dell’UE che hanno ottenuto raccolti superiori a quelli del 2020 sono Germania, Portogallo, Romania e Ungheria.• Le prime previsioni sul raccolto statunitense indicano un volume di produzione appena superiore a quello 2020.• Anno particolarmente positivo per i vigneti dell’emisfero australe, dove le condizioni metereologiche relativamente favorevoli hanno contribuito a livelli di produzione record in America del Sud, Sudafrica e Australia, con l’eccezione della sola Nuova Zelanda.ReplayComunicato Stampa Prezentazione PPT [EN]Produzione di vino 2021 - Prime stime
24 Ott 2021
L’Assemblea generale ha deliberato di spostare la sede dell’OIV trasferendo il Segretariato da Parigi a Digione. I 48 Stati membri hanno accettato l’offerta della Francia di dare all’OIV una sede che garantisca all’Organizzazione stabilità temporale, giuridica e finanziaria.Leggi il comunicato stampa completo
11 Ott 2021
To attend this online press conference, journalists are kindly asked to register here.• Date: Thursday 4th November 2021• Time: 3pm CET• Location: OIV App (soon available)• Language: English, French, Spanish
06 Ott 2021
Ildegarda di Bingen (1098-1179)Azélina Jaboulet-Vercherre Professoressa associata, Ferrandi Paris In un'epoca i cui turbamenti sono collettivamente noti, lo sguardo si volge alla ricerca di concetti storici che ci permettano di affrontare i tormenti dei nostri tempi. L'agricoltura, così come la (para-)medicina, si orientano alla comprensione olistica del mondo, facendo risorgere alcune personalità del nostro passato collettivo. L'allegoria della natura torna alla mente di tutti, in maniera più o meno consapevole, portandoci a varcare un universo fantastico d'altri tempi. Potrebbe essere medievale, come quello di Bernardo Silvestre, autore nel XII secolo di una Cosmographia nella quale la Natura è manovrata da una madre natura ancor più potente: Noys. Intelletto, saggezza e Divina Provvidenza, Noys intima alla Natura il corso da seguire per ristabilire l'ordine a partire da un caos macrocosmico1. Assieme, queste due nature superiori potrebbero ristabilire l'armonia tra le specie. Ildegarda di Bingen, un ordinamento spirituale "olistico" Per ritrovare lo sguardo d'altri tempi, restiamo in quello stesso XII secolo che portò al rinnovamento del naturalismo2, con Ildegarda di Bingen (1098-1179). Monaca, letterata, medica, profetessa e musicista, Ildegarda dimostra nelle sue opere una sensibilità al ritmo della natura che la rende un'illustre iniziatrice degli attuali adepti della biodinamica. Le sue opere mettono in risalto la stretta correlazione tra i movimenti interni del corpo e la Natura (forze vitali), in particolare la sua opera scientifica Physica, anche detta Liber subtilitatum, oppure il Liber simplicis medicine (risalente al 1150 circa)3. Essa presenta, in veste enciclopedica, un inventario della Creazione, a cui concorrono la cosmologia, la cosmografia, gli uomini e le loro attività, come l'impianto delle viti e la raccolta dell'uva, nonché le malattie e le relative cure. Pur discostandosene spesso, Ildegarda conosceva i classici. La sua originalità abbraccia numerose dimensioni, tra cui non ultima quella di aver dimostrato come l'essere donna non le impedisca necessariamente di essere riconosciuta, se non addirittura stimata, dai più grandi del suo secolo. (Bernardo di Chiaravalle, papa Eugenio III). Eppure, come spesso accade alle menti eccezionali, cadde in dimenticanza e fu dichiarata "Dottoressa della Chiesa" solamente il 7 ottobre del 20124. Tuttavia, ben più importante per noi è il suo ordinamento spirituale dei saperi che definiremo "olistico". La visione ildegardiana del creato Oltre alla sua conoscenza della terra, in quanto uno dei quattro elementi costitutivi dell'universo, si interessa ai diversi tipi di terreno e al loro utilizzo5. In Cause et Cure, (Cause e cure delle infermità) Ildegarda esprime l'estensione del suo approccio naturalista, dominato dal ruolo degli astri, il sole e la luna («che è madre di ogni tempo»)6. In quest'opera allude in particolare all'influenza della luna sulla coltivazione della vite (impianto, vendemmia, qualità della vite, ma anche alterazione dei frutti) e la nozione di terroir (gerarchia dei terreni in base all'esposizione al sole e all'umidità, qualità dell'uva a seconda delle regioni in cui la vite cresce). «Le piante delle regioni orientali, irrigate dalle acque orientali crescono bene e danno un buon raccolto di vari frutti dal buon sapore… Le viti, invece, in Oriente danno un gran raccolto di uve e un ottimo vino. [….] … nelle regioni occidentali… il vino è forte, ma non squisito, anche se si conserva, poiché lì la terra ha sia il caldo sia il freddo. […] […] la vite, invero, cresce meglio col caldo che col freddo7.» La visione ildegardiana del creato si basa sul sistema di riferimento della Genesi: «Quando l'uomo fu creato, una terra particolare fu estratta dalla terra: l'uomo. […] E la terrà offrì il suo vigore, secondo la specie e la natura e le usanze e tutto l'ambiente dell'uomo»8. La Creazione sia benefica, facendone un uso ragionato e sano Oltre alla reattività tra il principio divino e l'organizzazione della natura (fisica e umana), si nota l'emergere di un effetto di specularità, vero e proprio topos medievale nei ragionamenti sul cosmo. Il fatto che gli uomini siano soggetti a regole superiori si ripercuote su di noi, spesso a nostre spese. Quest'esigenza di umiltà ci pone d'innanzi alla forza della natura, a cui siamo sottoposti e che ci nutre, piuttosto che il contrario. Per la badessa visionaria, i movimenti del sole rivelano una lezione morale: «E se infrange la giustizia con le sue azioni, [l’uomo] opprime e oscura il sole e la luna, i quali, riflettendo il suo operato, producono tempeste, piogge e siccità […] .9» «Quando in inverno il sole cala, il fuoco, attraverso il ghiaccio, la galaverna e la grandine, è al servizio della giustizia. Attraverso il fuoco, il freddo e tutte le altre piaghe, a ogni peccato è così inflitta la pena che gli spetta10.» Queste frasi potrebbero essere considerate come rimproveri, ma sembrerebbe che lo scopo della "Sibilla del Reno" fosse piuttosto di ricordarci di come la Creazione sia benefica, facendone un uso ragionato e sano. _____________________ 1 Bernardo Silvestre, Cosmographie, Parigi, Cerf, 1998. 2 Bernard Ribémont, De Natura Rerum. Etudes sur les encyclopédies médiévales, Orléans, Paradigme, 1995, p. 89. 3 Il titolo Physica appare nell'edizione principe. Per maggiori informazioni sulle opere su cui questo studio si basa, si vedano i lavori di Laurence Moulinier, in particolare "La terre vue par Hildegarde de Bingen" (marzo 2005), 205-230. 4 Michel Trouvé e Pierre Dumoulin, presentazione del testo di Ildegarda di Bingen, Les mérites de la vie. Principes de psychologie chrétienne, Editions des Béatitudes, 2014, p. 5 Le livre des subtilités des créatures divines (Liber subtilitatum), trad. P. Monat, Grenoble, 1988, t. 1 p. 29-31. 6 Ildegarda di Bingen, Cause e cure delle infermità, ed. e trad. Paola Calef, Sellerio, Palermo, 1997 (Libro primo, "Del significato della luna"). 7 Ildegarda di Bingen Cause e cure delle infermità, ed. e trad. Paola Calef, Sellerio, Palermo, 1997 (Libro primo, "Del ricavato dalle piante, dai cereali e dalla vite"). 8 Ildegarda di Bingen, Libro delle Creature: differenze sottili delle nature diverse, ed. Antonella Campanini, Carocci, Roma. 9 Ead., p. 31 (traduzione della citazione dal francese). 10 Le livre des œuvres divines: Visions, presentato e tradotto da Bernard Gorceix, Paris, Albin Michel (coll. "Spiritualités vivantes, Sér. Christianisme"), p. 39-40 (traduzione della citazione dal francese).
05 Ott 2021
L’OIV lancia un nuovo evento internazionale sulla trasformazione digitale del settore, riunendo esperti di diversi paesi provenienti da accademia, governi, organizzazioni internazionali, e dal settore privato. Durante l’evento saranno anche presentati i risultati preliminari del report prodotto dall’osservatorio dell’OIV.Per partecipare al simposio potete registrarvi qui.Data: Mercoledì 24 novembre 2021Ora: 11 CETLocation: online – app eventi OIVLingue: EN - traduzione simultanea in francese e spagnoloPanelisti:Esperti internazionali in digitalizzazione con diversi background (università, sttore pubblico nazionale e internazionale, settore privato)Audience:L’evento sarà pubblico e diretto a un’ampia audience.
28 Set 2021
In uno scenario che vede aumentare l’interesse del settore vitivinicolo per i metodi di produzione ecologica, The World Organic Vineyard, il nuovo Focus dell’OIV dedicato al vigneto biologico mondiale, getta luce sull’affermarsi della viticoltura biologica, una tendenza in espansione dalla fine del XX secolo. Questo incremento deriva in larga misura da questioni di rilevanza sociale, inerenti in particolare alla salute dei consumatori e alla difesa dell’ambiente.Questa relazione esamina l’aumento e la distribuzione di vigneti con certificazione biologica destinati alla produzione di uva da vino, uva da tavola e uva passa nel periodo compreso fra il 2005 e il 2019.Si è assistito a un incremento a livello globale dei vigneti biologici, oltre che a una notevole diffusione della certificazione.Dall’inizio del XXI secolo, la conversione dei vigneti al regime biologico è aumentata in modo considerevole. Nell’intero periodo preso in esame dalla relazione (2005–2019) si è registrata un’espansione annua dei vigneti con certificazione biologica pari in media al 13%, laddove la superficie di vigneto “non-biologico” è diminuita in media dello 0,4% ogni anno. Una tale crescita si spiega anche con il fatto che la viticoltura biologica certificata rappresenta ancora un fenomeno recente.Nel 2019, ben 63 paesi di tutto il mondo hanno adottato la viticoltura biologica; si stima che i vigneti con certificazione biologica abbiano coperto una superficie di 454 mha, pari al 6,2% del totale delle aree vitate del mondo.Spagna, Francia e Italia ospitano complessivamente il 75% dei vigneti a regime biologico.Se si considera la percentuale di vigneti biologici rispetto alla superficie vitata totale a livello nazionale, la classifica è dominata dai paesi europei. In Italia il 15% dei vigneti è coltivato a regime biologico; seguono la Francia (14%) e l’Austria (14%). L’unico paese non europeo a rientrare nei primi dieci paesi di questa classifica è il Messico, dove i vigneti con certificazione biologica rappresentano l’8% del totale.Occorre tuttavia tenere presente che l’aumento dei vigneti biologici su scala globale è segnato da una dinamica altalenante, poiché in molti casi la conversione alla viticoltura biologica è un processo complesso che richiede un adattamento notevole. I fenomeni meteorologici, così come eventuali questioni strutturali e/o di tipo organizzativo, potrebbero spingere i produttori a rinunciare alla certificazione biologica, con la conseguente riduzione delle superfici vitate biologiche a livello locale.
27 Set 2021
19 Set 2021
Lo scorso venerdì 10 settembre si è concluso il Corso internazionale di ampelografia dell’OIV. Il direttore generale dell’OIV, Pau Roca, e il vice-assessore all’ambiente, all’assetto del territorio e allo sviluppo sostenibile della Comunità autonoma di Madrid, Mariano González Saez, hanno consegnato ai 25 iscritti, di 9 nazionalità diverse, un attestato di partecipazione e un’illustrazione artistica della varietà endemica Rayada Melonera. Rayada Melonera. Varietà endemica della Comunità di Madrid. Disegno di Anne Pieussergues Dherbicourt.La nuova edizione del corso, organizzata dall’OIV in collaborazione con l’Istituto madrileno di ricerca e sviluppo rurale, agricolo e alimentare (IMIDRA), è stato pensato come contributo attivo alla promozione dell’ampelografia attraverso la formazione dei nuovi professionisti del settore.L'ampelografia è una branca della botanica legata allo studio, alla descrizione e alla classificazione delle specie e delle varietà di viteQuesto Corso internazionale di ampelografia dell’OIV si iscrive nel percorso avviato nel 1988 in Italia (ISV Conegliano), continuato nel 1990 in Francia (ENSA Montpellier) e quindi nel 1992 in Germania (BZWG-IR Geilweilerhof).Nel 2021, gli specialisti di questa disciplina si sono riuniti a La Finca El Encin.Nel 2021 gli specialisti della disciplina si sono ritrovati presso la Finca El Encín, il centro di riferimento della Comunità autonoma di Madrid per progetti di ricerca agroalimentare e agroambientale, che si trova a Alcalá de Henares. I lavori del Dipartimento di ricerca agroalimentare, diretto da Gregorio Munoz e Felix Cabello, mirano all’ottenimento di vini di qualità e alla conservazione e lo studio dei vitigni autoctoni. Il programma di questi cinque giorni di formazione ha proposto l’intervento di insegnanti internazionali di altissimo livello che hanno unito la teoria – nell’antica cappella del sito riconvertita per l’occasione – alla pratica, in una collezione che, con quasi 4000 varietà di vite, è la più ricca di Spagna e tra le più importanti del mondo. El Encín ospita una delle collezioni di vigneti più importanti del mondo.La prossima edizione del corso si terrà a luglio 2022 a Montpellier (Francia), con la collaborazione dell’IFV (Istituto francese della vigna e del vino), dell’INRAE (Istituto nazionale di ricerca per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente) e dell’Istituto Agro - Montpellier SupAgro. La presenza di Thierry Lacombe, ampelografo francese e ingegnere all’INRAE di Montpellier, durante l’intera settima è servita a facilitare questo passaggio di testimone. L’iniziativa rientra nei lavori condotti attualmente dalla Commissione “Viticoltura” e dal Gruppo di esperti “Risorse genetiche e selezione della vite” (GENET). Luigi Bavaresco, presidente del Gruppo GENET, ha partecipato all’inaugurazione e a una parte delle lezioni presentando i lavori in corso e quelli futuri. Per maggiori informazioni sul lavoro della Commissione “Viticoltura”, si prega di contattare Alejandro Fuentes Espinoza, capo dell’unità “Viticoltura” viti@oiv.int e/o Solange Slack, responsabile dei progetti OIV comunication@oiv.int.Per maggiori informazioni sull’edizione 2022 del corso, si prega di contattare oivampelography@oiv.int Ritrovate anche le testimonianze degli insegnanti e dei partecipanti.
15 Set 2021
La 52ª riunione del Comitato del Codex sugli additivi alimentari (CCFA) si è svolta in modalità telematica dall’1 al 10 settembre 2021 su gentile invito del governo cinese. Durante la riunione, a cui ha partecipato il coordinatore scientifico dell'OIV Jean-Claude Ruf, sono state approvate diverse decisioni.Dr. Yongxiang Fan, Presidente del Comitato del Codex sugli additivi alimentariIn particolare, su proposta della delegazione cilena, il Comitato ha discusso della possibile ripresa dei lavori sugli additivi nel vino in seno al Codex Alimentarius. Questi lavori sono sospesi dal 2017 per la mancanza di consenso circa il riferimento all’OIV in una nota a piè di pagina relativa all’applicazione delle buone pratiche di fabbricazione (BPF).Durante la riunione è stato quantomeno espresso un consenso alla ripresa delle discussioni vista l’importanza di aprire nuovamente questi lavori nell’ambito del commercio internazionale.Sebbene la competenza dell'OIV venga riconosciuta da molti paesi, alcuni membri ritengono che le norme del Codex dovrebbero essere elaborate e applicate a livello mondiale e non dovrebbero fare riferimento a norme stabilite da altre organizzazioni; altri, favorevoli ai lavori, hanno sottolineato l’importanza di ottenere delle informazioni pertinenti da parte dei membri.L’OIV ha esortato a una collaborazione più stretta tra il CCFA e l’OIV al fine di evitare la duplicazione di norme internazionali per il vino d’uva.In veste di osservatore presso il Codex Alimentarius, l’OIV ha preso atto delle preoccupazioni espresse dai membri e ha sottolineato la sua disponibilità a partecipare ai lavori offrendo il proprio contributo in uno spirito di compromesso. In conclusione, il Comitato ha deciso che il Cile, in collaborazione con l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, preparerà un documento di discussione per la prossima riunione del CCFA e che la lista degli additivi per la categoria dei vini d’uva in attesa di approvazione verrà mantenuta alle fasi attuali.Inoltre, il Comitato ha chiesto al JECFA di rivalutare i limiti di piombo nelle monografie sulla bentonite, le diatomee e il carbone attivo. Sulla base delle valutazioni del JECFA, le corrispondenti monografie del Codex enologico internazionale dell'OIV potrebbero essere sottoposte a revisione.
13 Set 2021
Lo scorso 9 settembre, a Parigi, la Giuria internazionale dell'OIV, composta dall’élite scientifica e tecnica di diversi Stati membri dell’Organizzazione, ha assegnato 16 Premi e 10 Menzioni speciali a pubblicazioni selezionate tra le circa sessanta in gara.
Qui l’Albo dei vincitoriPremi, menzioni speciali e riconoscimenti della giuria dei premi OIV 2021 La presidente della Giuria Azélina Jaboulet-Vercherre e il segretario scientifico Richard Pfister hanno ringraziato i numerosi lettori che da tutto il mondo hanno valutato con imparzialità e professionalità le pubblicazioni presentate. Sono quasi 40 i paesi rappresentati dagli autori e dalle molte persone che hanno contribuito alla redazione delle opere. L’edizione 2021 evidenzia il grande rigore degli autori, sostenuti dalle loro squadre editoriali, e la qualità delle fotografie presenti nelle opere. Il lavoro di tre fotografi è stato quindi premiato con il Riconoscimento della Giuria: Christophe Deschanel, Gerda Louw et Sophie Dumont. Il Riconoscimento della Giuria dell’OIV 2021 è stato assegnato, come sempre, nel pieno rispetto degli obiettivi del Premio dell'OIV stabiliti nel 1930: promuovere la ricerca in tutti i paesi e diffondere le conoscenze sulla vite e sul vino nel mondo. Le iscrizioni per l'edizione 2022 dei Premi dell’OIV sono aperte dal 1º settembre al 28 febbraio 2021.
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina